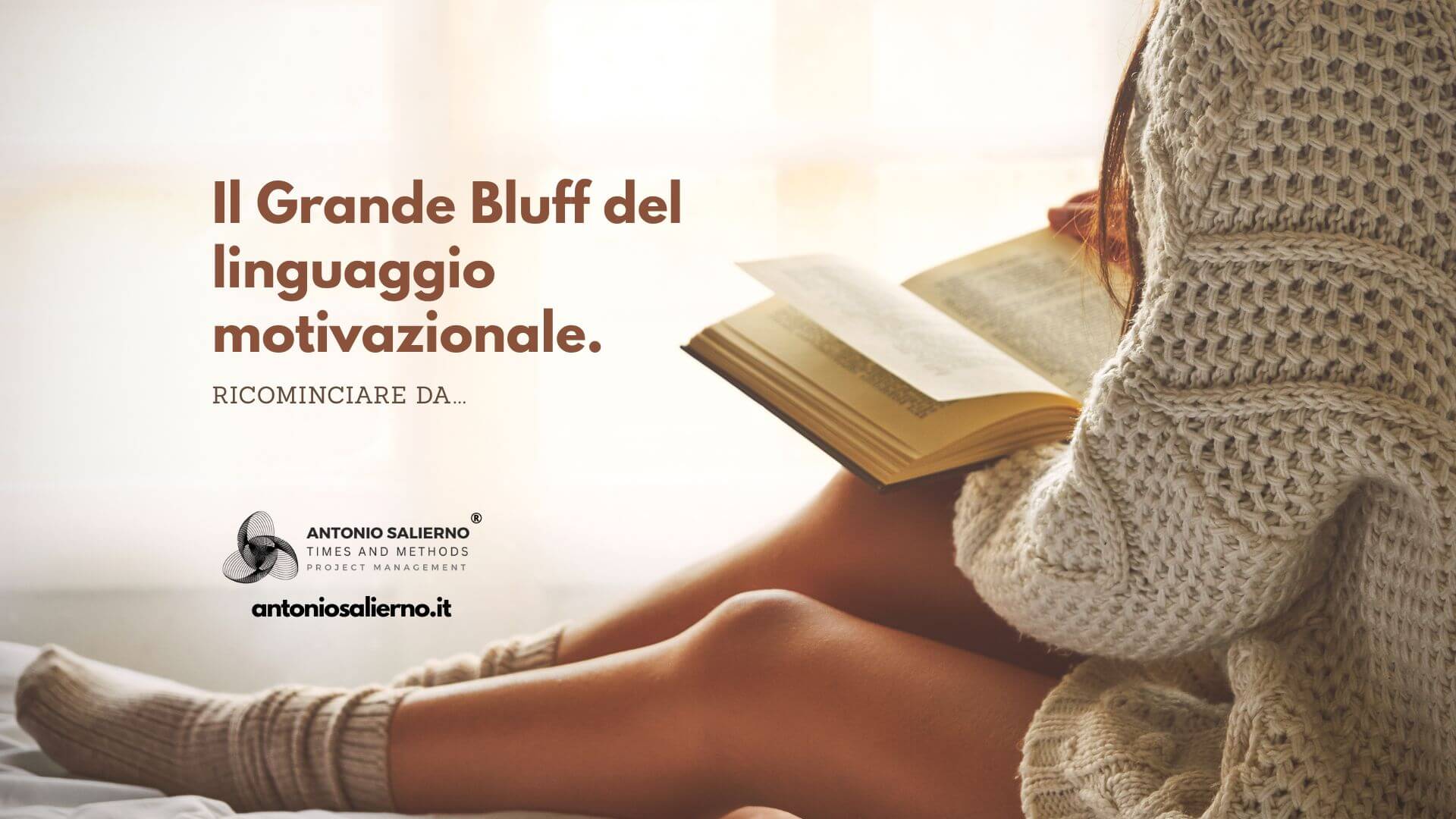Il Grande Bluff del Linguaggio Motivazionale. Ricominciare da…
C’è un fenomeno che si insinua silenzioso tra le pieghe della comunicazione moderna, e che trova il suo apice nel momento in cui un giovane entra nel mercato del lavoro: l’impoverimento del linguaggio. Non si tratta solo di usare meno parole, ma di usarne sempre le stesse, sempre più vuote, sempre più scollegate da un pensiero autentico. È come se il vocabolario si fosse ridotto a un kit di sopravvivenza aziendale: “resilienza”, “leadership”, “innovazione”, “mindset”. Parole che rimbalzano tra i corridoi degli open space come palline antistress, senza mai toccare davvero il senso delle cose.
Il giovane, fresco di laurea e pieno di entusiasmo, si presenta al colloquio con un lessico che sembra uscito da un generatore automatico di frasi motivazionali. Non parla, pitcha. Non pensa, brainstorma. Non propone, lancia idee disruptive. E se gli chiedi cosa intende per “disruptive”, ti guarda come se gli avessi chiesto di declinare un verbo latino. Il linguaggio è diventato una performance, una coreografia verbale che deve suonare bene, non significare nulla.
E qui entra in scena l’intelligenza artificiale, che con la sua prodigiosa capacità di generare testi ha creato un fiume di contenuti che scorrono ovunque: nei post su LinkedIn, nelle descrizioni aziendali, persino nei messaggi di benvenuto delle newsletter. Un fiume del nulla, che attraversa tutti. L’IA non ha colpa, poverina: fa quello che le chiediamo. Ma se le chiediamo di scrivere come scriviamo noi, e noi scriviamo come parliamo, e parliamo come se stessimo recitando uno spot pubblicitario, il risultato è una lingua che non comunica, ma decora.
Il paradosso è che più si cerca di apparire professionali, più si finisce per sembrare generici. Il linguaggio si appiattisce, si standardizza, si svuota. E così, nel mercato del lavoro, si assiste a una strana forma di selezione: non si cerca chi sa parlare, ma chi sa ripetere. Chi sa usare le parole giuste, nel giusto ordine, con il giusto tono. Un po’ come un incantesimo: se dici “proattività” abbastanza volte, forse il lavoro arriva.
Nel frattempo, parole vere, parole vive, parole che raccontano esperienze, dubbi, idee, emozioni, vengono messe da parte. Non c’è spazio per la complessità, per la sfumatura, per il pensiero critico. E allora nascono neologismi come “schiridibozi”, che non significano nulla ma suonano bene. E se suonano bene, allora vanno bene. Perché oggi, nel mondo del lavoro, il significato è secondario. L’importante è il suono. L’importante è che sembri professionale. L’importante è che il tuo profilo LinkedIn abbia almeno tre endorsement per “comunicazione efficace”.
Ma comunicare non è solo usare parole. È scegliere le parole giuste. È sapere cosa si vuole dire. È avere qualcosa da dire. Come recitarle e con quale pensiero critico. E forse è proprio questo che manca: non le parole, ma il pensiero dietro le parole. Il coraggio di dire qualcosa che non sia già stato detto mille volte. Il coraggio di non essere “in linea con la vision aziendale”, ma di avere una visione propria.
E allora, forse, il vero atto rivoluzionario oggi è parlare davvero. Dire cose vere. Usare parole vere. Anche se non sono “cool”. Anche se non sono “scalabili”. Anche se non piacciono all’algoritmo.
Ecco alcune opere significative degli autori che possono aiutare a ritrovare il gusto della lingua italiana, quella che non si piega al marketing né all’algoritmo, ma che respira, pensa e resiste.
Natalia Ginzburg ha scritto pagine memorabili in “Lessico famigliare”, dove la lingua è intima, quotidiana, ma mai banale. È un libro che insegna come le parole costruiscano legami, memorie, identità. Un altro testo prezioso è “Le piccole virtù”, una raccolta di saggi che riflette con lucidità e delicatezza sulla vita, l’educazione, il tempo.
Italo Calvino è un maestro del gioco linguistico e della precisione. In “Le città invisibili”, la lingua diventa architettura, sogno, filosofia. In “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, invece, il lettore è trascinato in un esperimento narrativo che mette in discussione il senso stesso della lettura. E poi c’è “Lezioni americane”, dove Calvino riflette sul valore della leggerezza, della rapidità, della visibilità: parole che oggi sembrano slogan, ma che lui trattava come virtù letterarie.
Elsa Morante, con “La storia”, ha scritto uno dei romanzi più intensi del Novecento italiano. La lingua è potente, dolorosa, necessaria. In “L’isola di Arturo”, invece, la scrittura si fa lirica, evocativa, capace di raccontare l’adolescenza con una profondità che oggi sembra scomparsa.
Cesare Pavese ha lasciato un’eredità linguistica fatta di malinconia e precisione. In “La luna e i falò”, la lingua è asciutta, ma piena di risonanze. Nei “Dialoghi con Leucò”, invece, Pavese usa il mito per interrogare l’esistenza, con una lingua che è riflessione pura.
Dario Fo, con “Mistero buffo”, ha reinventato il linguaggio teatrale, mescolando dialetto, grammelot, satira e poesia. È una lettura che mostra come la lingua possa essere ribelle, comica, politica.
Amelia Rosselli, in raccolte come “Serie ospedaliera” o “Documento”, ha spinto la lingua poetica verso territori nuovi, frantumati, musicali. Giovanni Giudici, con “La vita in versi”, ha saputo raccontare il quotidiano con ironia e profondità. Patrizia Cavalli, in “Sempre aperto teatro”, ha scritto poesie che sembrano conversazioni, ma che nascondono una precisione chirurgica.
Paolo Cognetti, con “Le otto montagne”, ha riportato la lingua alla natura, alla solitudine, alla concretezza. Donatella Di Pietrantonio, in “L’Arminuta”, ha usato una lingua essenziale per raccontare l’abbandono, la famiglia, l’identità.
Queste opere non sono solo belle: sono necessarie. Sono un invito a tornare a una lingua che non serve per vendere, ma per capire, per dare una netta identità a chi siamo e a cosa diciamo. Leggerle significa scegliere di pensare, di sentire, di parlare davvero — dimenticando per sempre uno “schiridibozi”, quel termine inutile che si aggira tra i giovanissimi lavoratori come un badge aziendale obbligatorio, mentre cercano di scrivere il futuro con parole che non hanno mai scelto davvero.
Condividi l'articolo