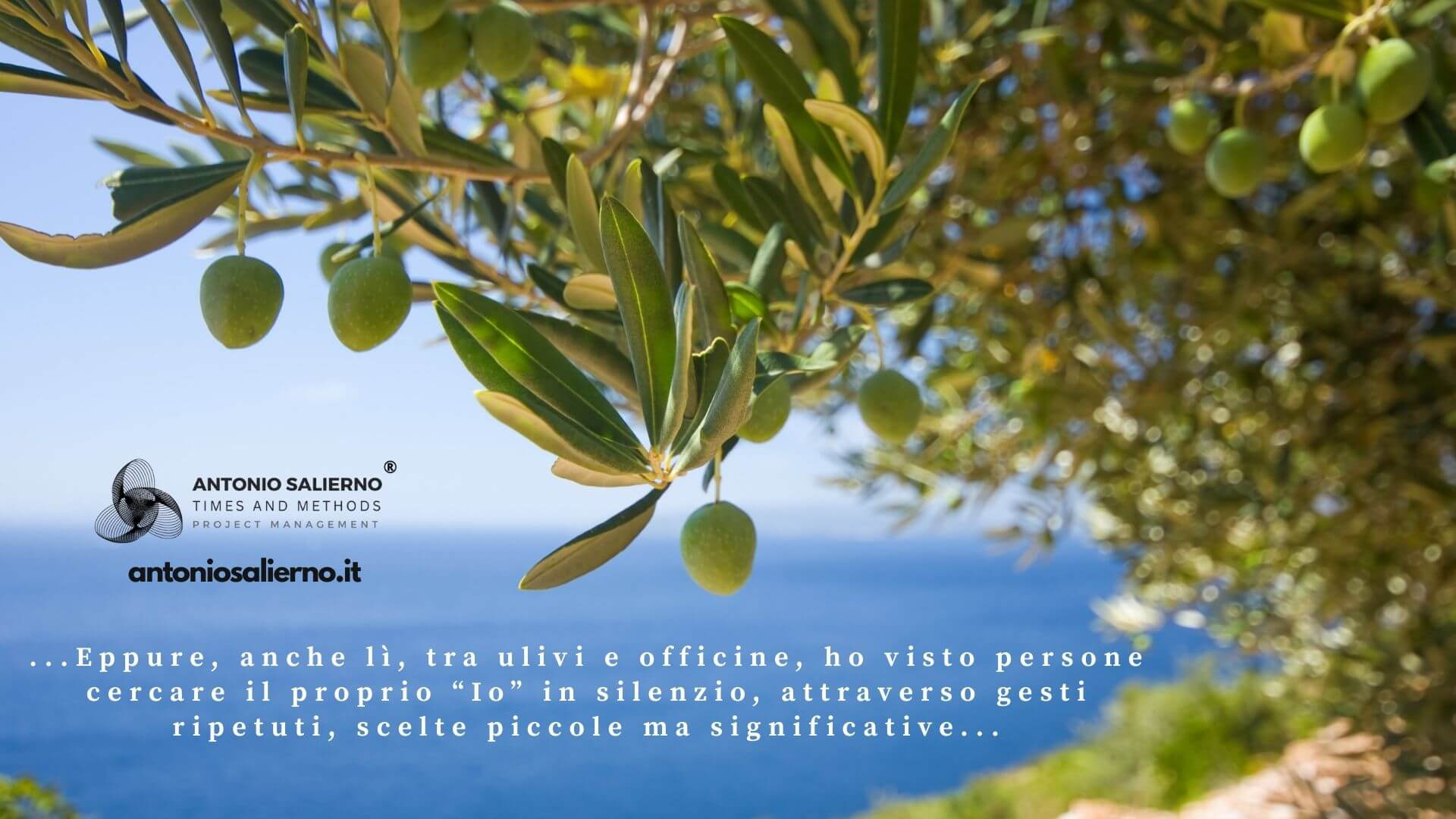Il mestiere di essere, dalla Puglia alla Toscana
In un’epoca in cui il lavoro è spesso ridotto a una funzione economica o a una misura di successo sociale, è fondamentale riscoprirne la dimensione più profonda: quella esistenziale.
La ricerca di sé attraverso il lavoro non è un percorso lineare né semplice, ma è una delle strade più autentiche per costruire un’identità solida e consapevole. E per intraprenderla, serve determinazione. Non quella cieca, ma quella che nasce dal desiderio di vivere in coerenza con ciò che si è.
La psicologia del lavoro, nata nei primi decenni del Novecento, ha da tempo riconosciuto che l’attività professionale è un luogo in cui si riflette, si agisce, si sbaglia e si cresce. Mi sono imbattuto più volte nel manuale Introduzione alla psicologia del lavoro di Guido Sarchielli e Franco Fraccaroli, pubblicato nel 2023. Gli autori sottolineano come il lavoro sia una componente centrale dell’identità personale, non solo un mezzo di sostentamento. È un campo di esperienza che ci mette in contatto con le nostre capacità, i nostri limiti e le aspettative sociali.
Un concetto che ho trovato illuminante è quello del “Sé professionale”, esplorato da Loretta Fabbri e Bruno Rossi nel loro progetto del 2014 sulla formazione dell’identità professionale. Secondo loro, il lavoro non è solo un insieme di compiti, ma un processo di costruzione del sé che richiede progettualità, intenzionalità e coraggio. L’individuo, nel suo percorso professionale, è chiamato a scegliere, a prendere posizione, a rinunciare al disordine per dare forma a un progetto di vita significativo. Questo approccio pedagogico mi ha colpito per la sua profondità: non si tratta solo di fare, ma di capire perché si fa.
Anche la sociologia ci offre strumenti preziosi. William James, già nel 1890, distingueva tra l’Io attivo e il Me riflessivo. L’Io è colui che agisce, prende decisioni e partecipa all’esperienza; il Me è ciò che conosciamo di noi stessi, il modo in cui ci vediamo e ci rappresentiamo. Il lavoro, in questo senso, è un teatro in cui entrambi si manifestano: ci espone, ci costringe a confrontarci con gli altri e con noi stessi, ci permette di costruire un’immagine coerente e dinamica del nostro essere.
Durante la pandemia, ho letto con interesse gli studi dell’Università di Padova, come quello condotto e pubblicato nel 2025 sullo smart working e il benessere psicologico. Questi studi mostrano come il lavoro, in condizioni di isolamento, abbia amplificato ansie e insicurezze, spingendo molte persone a rivedere le proprie priorità. In particolare, i giovani hanno vissuto un’accelerazione delle difficoltà già presenti: precarietà, frammentazione dei percorsi, senso di disorientamento. Questo ha generato una nuova domanda di senso, una spinta verso un lavoro che non sia solo produttivo, ma anche significativo.
In questo contesto, la determinazione diventa una forza trasformativa. Non è solo resistenza, ma capacità di cercare, di interrogarsi, di non accontentarsi. Trovare il proprio “Io” attraverso il lavoro significa accettare che ogni esperienza, anche quella più frustrante, può insegnare qualcosa. Significa credere che il lavoro non debba essere una gabbia, ma una finestra aperta sulla propria verità. E in questa verità, il “Io” non è un punto d’arrivo, ma un processo continuo. Un processo che richiede coraggio, riflessione e, sopra ogni cosa, la volontà di non smettere mai di cercare.
Ho letto studi, mi sono imbattuto in ricerche e testimonianze che confermano quanto il lavoro sia più di una funzione: è un viaggio. E come ogni viaggio, ha tappe, deviazioni, incontri e perdite. Molti hanno intrapreso questo cammino, consapevoli o meno.
Ricordo le prime esperienze in Puglia, dove il lavoro era spesso legato alla terra, alla tradizione, alla fatica fisica. Eppure, anche lì, tra ulivi e officine, ho visto persone cercare il proprio “Io” in silenzio, attraverso gesti ripetuti, scelte piccole ma significative.
In Lombardia, la ricerca si è fatta più strutturata, più ambiziosa. Tra fabbriche, uffici e poli tecnologici, uomini e donne si sono interrogati sul senso del fare, sul peso del ruolo, sulla possibilità di essere sé stessi anche dentro una gerarchia. E infine in Toscana, dove il lavoro spesso si intreccia con l’arte, con la bellezza, con la cura del dettaglio, ho incontrato professionisti che, pur immersi in contesti diversi, continuavano a cercare un centro, una coerenza, una voce interiore.
Indipendentemente dal ruolo ricoperto — operaio, dirigente, artigiano, consulente — la ricerca dell’identità non ha confini. Passa attraverso fallimenti, cambi di rotta, intuizioni improvvise. Osservare queste persone, e osservarsi mentre le si osserva, è stato per me fondamentale. Perché il lavoro non è solo ciò che si fa, ma anche ciò che si vede negli altri. È uno specchio che riflette e distorce, che mostra ciò che siamo e ciò che potremmo essere.
E poi c’è stato lui. Il mio primo capo. Non lo citerò per nome, ma la sua figura è scolpita nella mia memoria. Un ingegnere, conosciutissimo ma che odiava essere riconosciuto, burbero alla prima impressione, con la voce che sembrava scolpita nel marmo e la postura di chi ha attraversato molte tempeste. Ma dietro quella scorza, c’era una maestria nell’orazione che non ho più ritrovato altrove. Parlava, e quando lo faceva, ogni parola aveva peso, ritmo, direzione. Aveva una connaturazione fortemente naturale del suo “Io”, una presenza che non cercava di piacere, ma di essere. Aveva ricoperto ruoli nazionali nelle più importanti aziende a partecipazione statale del paese, eppure non ostentava nulla. Era come se il suo “Io” fosse già stato forgiato, temprato, definito.
Quell’incontro ha forgiato anche me. Ho scremato alcune parti di me che non mi appartenevano, ne ho acquisite altre che sentivo vere. Osservare lui è stato come osservare una versione possibile di me stesso, una traiettoria che non avevo considerato. E da allora ho capito che osservare gli altri non è solo un atto di curiosità, ma di costruzione. Osservarsi, invece, è il passo successivo: è il momento in cui si decide cosa tenere, cosa lasciare, cosa trasformare.
La ricerca del proprio “Io” attraverso il lavoro è un atto di coraggio. È scegliere di non vivere in automatico, di non accontentarsi di ruoli e titoli. È accettare che ogni giorno, ogni incontro, ogni errore può essere una tappa del viaggio. E che osservare — con attenzione, con rispetto, con apertura — è il primo passo per riconoscersi. E forse, anche per ritrovarsi.
Condividi l'articolo