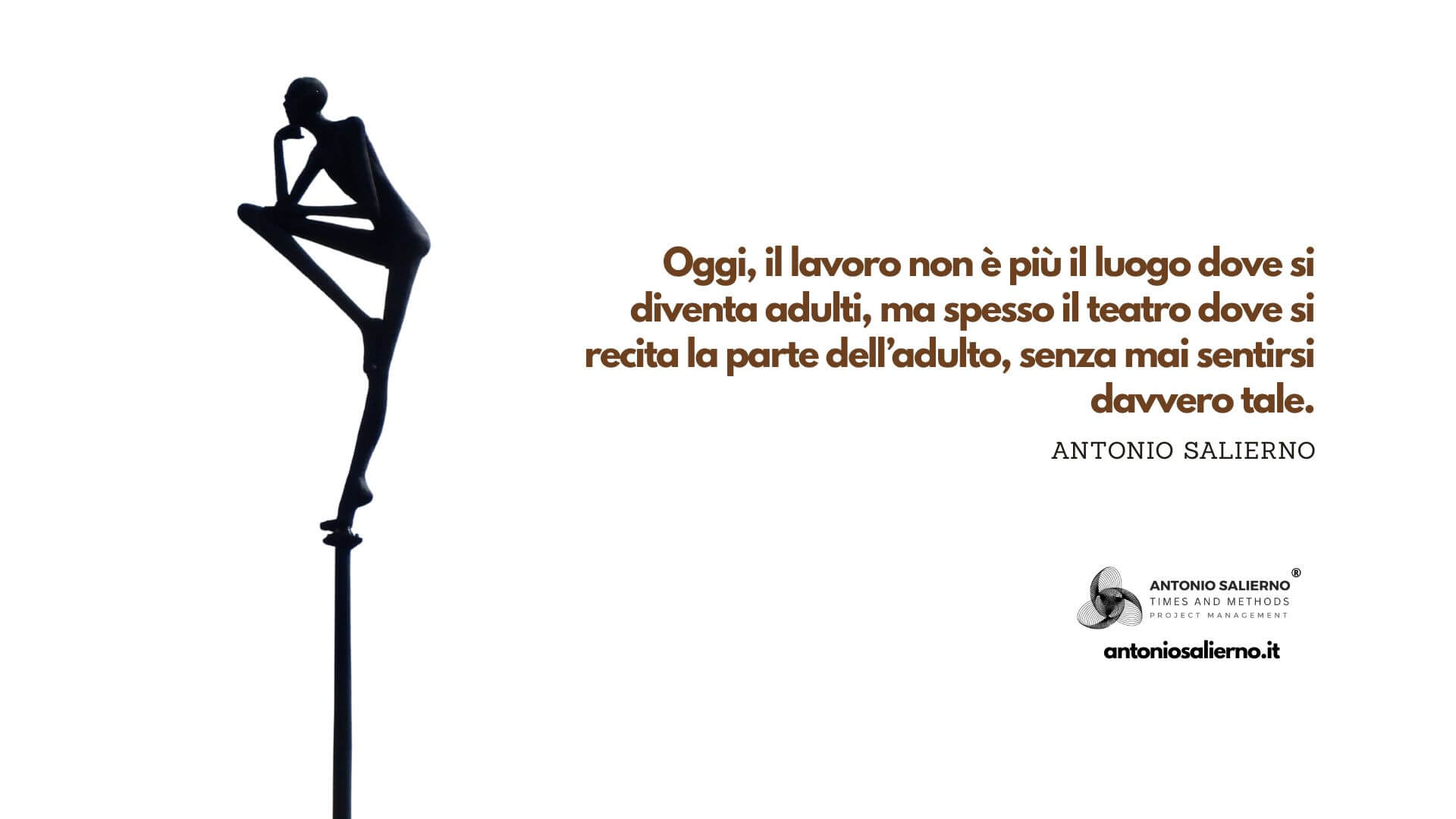Il rovescio del fare: anti-work e la poetica del gesto
Nel cuore dell’Italia del 2025, il lavoro giovanile non è più soltanto un problema economico, ma una questione esistenziale che interroga il senso stesso del vivere in una società che ha smarrito il valore del tempo e della dignità. I dati ISTAT, pubblicati pochi giorni fa, che parlano di una disoccupazione giovanile oltre il 20% e di un tasso di inattività che sfiora il 33%, non sono solo cifre, ma sintomi di una frattura profonda tra le promesse della modernità e la realtà di una generazione che si sente tradita, cresciuta con l’idea che l’impegno scolastico e la formazione avrebbero garantito un futuro stabile, si ritrova invece in un presente fatto di contratti a termine, stage non retribuiti e un mercato del lavoro che sembra più un labirinto che un percorso.
In questo scenario, il fenomeno dell’“anti-work” non è una semplice moda o una ribellione giovanile contro le responsabilità, ma piuttosto una forma di resistenza lucida e profonda. È come se molti giovani stessero dicendo: non voglio entrare in un gioco dove le regole sono truccate. Il lavoro, così com’è strutturato oggi, non viene più percepito come uno spazio di crescita o di realizzazione, ma come una macchina che consuma tempo, energie e senso, lasciando in cambio solo precarietà e frustrazione.
Questa posizione non nasce dal rifiuto del fare, ma dal rifiuto di un sistema che riduce il valore umano alla produttività, come se l’unico modo per “valere” fosse produrre, correre, competere. In questo senso, il pensiero di Ivan Illich sulla scuola diventa sorprendentemente attuale: lui vedeva l’istruzione come un meccanismo che, invece di liberare, insegnava a obbedire, a conformarsi, a occupare il proprio posto nel sistema. Oggi, molti giovani vedono il lavoro allo stesso modo: non come un diritto, ma come una gabbia, dove si entra per necessità e si resta per paura.
Il rifiuto del lavoro tradizionale, quindi, è una forma di disobbedienza creativa, un modo per cercare alternative, per immaginare un altro modo di vivere, dove il tempo non sia solo una risorsa da monetizzare, ma uno spazio da abitare. È come se stessero cercando di riappropriarsi della propria vita, sottraendosi a un sistema che li vuole sempre disponibili, sempre efficienti, sempre misurabili.
Se Max Weber vedeva nel lavoro la vocazione dell’individuo moderno, oggi quella vocazione somiglia a una campana che suona in una valle vuota: il suo richiamo risuona, ma nessuno risponde, non perché non ci siano orecchie, ma perché non c’è più fede nel suono. Il lavoro, che un tempo era il fulcro attorno a cui ruotava l’identità, è diventato un luogo di smarrimento, una stanza senza finestre dove si entra per necessità e si esce, spesso, più confusi di prima.
Marx lo aveva già intuito: l’operaio separato dal prodotto del suo lavoro non è solo alienato, è spogliato della propria creatività, come un pittore costretto a dipingere sempre lo stesso cielo grigio, senza mai poter scegliere il colore. Il lavoro, in questa visione, non è più espressione, ma ripetizione, non è più costruzione, ma consumo di sé.
Zygmunt Bauman, con la sua modernità liquida, ci offre una metafora ancora più inquietante: il lavoro è come un ponte sospeso su acque mobili, dove ogni passo è incerto, ogni contratto è provvisorio, ogni progetto è una promessa che evapora. In questa liquidità, l’identità non si costruisce, si improvvisa, e il lavoratore diventa un giocoliere del tempo, costretto a tenere in aria competenze, relazioni, ambizioni, senza mai sapere se il prossimo lancio sarà l’ultimo.
Oggi, il lavoro non è più il luogo dove si diventa adulti, ma spesso il teatro dove si recita la parte dell’adulto, senza mai sentirsi davvero tale. È come indossare un abito troppo largo, cucito su misura per un modello di vita che non esiste più. I giovani lo percepiscono: non rifiutano il lavoro in sé, ma rifiutano il copione. Vogliono scrivere il proprio, anche se significa uscire dal palco, anche se significa restare dietro le quinte.
In questo scenario, l’eco della vocazione weberiana si perde tra le pareti di un mondo che ha cambiato architettura: non ci sono più cattedrali del lavoro, ma labirinti di mansioni, non ci sono più mestieri, ma task, non ci sono più carriere, ma percorsi a ostacoli. E forse, proprio in questo smarrimento, si cela la possibilità di una nuova forma di lavoro: non come destino, ma come scelta, non come identità imposta, ma come narrazione personale.
In questo contesto, il rifiuto del lavoro tradizionale assume i contorni di una nuova forma di agency, una scelta consapevole di sottrarsi, come dicevo, a un sistema che misura il valore umano in termini di produttività, un gesto che Michel Foucault avrebbe forse letto come una microresistenza al potere biopolitico, un modo per sottrarsi alla governamentalità neoliberale che trasforma ogni aspetto della vita in performance. Ma questa sottrazione non è una fuga: è una coreografia invisibile, un passo laterale che rompe il ritmo imposto, come chi in una danza collettiva decide di muoversi in controtempo, non per dispetto, ma per cercare una melodia diversa. Il giovane che rifiuta il lavoro non è un disertore, ma un compositore silenzioso che tenta di riscrivere la partitura della propria esistenza.
L’anti-work, in questa luce, non è il contrario del lavoro, ma il suo rovescio poetico: non nega il fare, ma ne contesta il senso, non rifiuta l’impegno, ma ne rifiuta la logica di accumulo, di prestazione, di sorveglianza. È come se il lavoro, da verbo transitivo, fosse diventato intransitivo, non più “fare per” ma semplicemente “fare”, senza destinatario, senza profitto, senza giudizio. In questa torsione semantica, il lavoro si avvicina all’arte, al gioco, alla cura: non più obbligo ma possibilità, non più condanna ma forma di espressione, come auspicava il mio maestro Domenico De Masi con la sua idea di ozio creativo, dove il tempo non è tempo perso, ma tempo ritrovato, dove la produttività lascia spazio alla fertilità, dove il valore non si misura in output ma in intensità.
Questa reinvenzione non avviene nei luoghi canonici del lavoro, ma nelle pieghe della quotidianità: in una stanza condivisa tra freelance, in un orto urbano coltivato da chi ha lasciato l’ufficio, in un podcast registrato di notte da chi di giorno consegna pacchi. Sono micro-utopie disseminate, laboratori di senso, dove il lavoro non è più una funzione sociale, ma una narrazione personale. E in queste narrazioni, spesso fragili, intermittenti, precarie, si intravede una nuova grammatica del vivere: una grammatica che non ha ancora regole fisse, ma che ha già un lessico fatto di libertà, di lentezza, di autenticità.
In questa tensione tra rifiuto e reinvenzione si gioca il futuro del lavoro, non solo per i giovani ma per l’intera società, che dovrà decidere se continuare a sacrificare intere generazioni sull’altare della produttività o se aprirsi a un nuovo paradigma, dove il lavoro sia al servizio della vita e non viceversa, paradossalmente restando produttivo.
Condividi l'articolo